“...e se non
pensa in ver né sente
il topo o il
can, di dubitar concesso
m’è del
sentire e del pensar mio stesso.”
(Batracomiomachia,
VII, 13)
Quale incontro mancato, e che fantastico divertimento è
stato tolto a noi altri da un Dio per l’ennesima volta in vena
di avarizia!
Perché Leopardi di Darwin sarebbe stato il cantore
geniale e irriverente, il bardo perfetto da gettare nella zuffa
inevitabile, dopo la scoperta che l’uomo non decadde da un
angelo ma emerse - giusto ieri e ancor non s’è ripreso! - da
una scimmia più sciammannata delle altre!
Leopardi lettore dell’Origine
delle specie avrebbe trovato conferme perfette
delle sue intuizioni del lato non solo scimmiesco ma volatile
dell’uomo, come di quello pre (o post?) umano degli uccelli!
Giochiamo a fare i plutarchini e dunque notiamo che le
date dei due in buona parte quasi coincidono, anche se Leopardi,
più vecchio di una decina d'anni, precede sempre l'inglese di un
paio di lunghezze.

Infatti, quando Leopardi scrive lo scandaloso Frammento
apocrifo di Stratone da Lampsaco (1825) in cui il
nostro mondo appare appena come uno degli infiniti possibili,
Charles Darwin sta per iscriversi alla facoltà di medicina di
Edimburgo, che abbandonerà però disgustato nel 1827: proprio
mentre Leopardi scrive Il
Copernico e il Dialogo
di Plotino e di Porfirio.
Quando poi Darwin comincia il viaggio sul Beagle, il 27
dicembre del 1831, a Leopardi, che ha pubblicato da pochi mesi la
prima edizione dei Canti,
manca una sola pagina per chiudere definitivamente lo Zibaldone.
Il 1836 è l’anno in
cui, mentre a Napoli esce la seconda edizione delle Operette morali, subito del resto sequestrata
dalla polizia, Darwin
torna dal suo lungo viaggio in Inghilterra: è ricco di materiali
e di taccuini. Soprattutto, coltiva la fondamentale intuizione sui
fringuelli delle Galapagos, tutti forse discendenti da una stessa
matrice.
Ma, mentre il Leopardi che nell’Elogio ponendo gli uccelli in
cima alla scala degli esseri fa la figura di un poeta con
l’hobby pedestre e domenicale d’una filosofia
cialtrona, la nuova osservazione
degli uccelli di Darwin sta per generare un terremoto universale
peggiore perfino del cosmo senza centro e senza bordi di
Copernico...
E, ahimè, quando, nel 1859, esce The Origin
of Species,
Leopardi
è già morto da ventidue anni,
e certo nessuno ricorda i testi che subito andiamo
a riassumere.

La visione del regno animale come un unicum in cui le
specie si dispongono secondo differenze appena graduali e mai di
sostanza, è presente in Leopardi già in scritti infantilissimi,
come la Dissertazione
sopra l’anima delle bestie (1811), scritta ad
appena 13 anni e in cui si legge che “sembrami di poter
concludere con sicurezza, che la sentenza, la quale afferma esser
l’anima dei Bruti uno spirito dotato di senso, di libertà, e di
un qualche lieve barlume di ragione è certamente più probabile
di ogni altra”.
Ancora una volta, cosa fosse il genio di Leopardi è
davvero misterioso anche solo provare a intuire. E stupefacente è
la circolarità tra questa conclusione d’un testo precocissimo,
e quanto si legge nei Paralipomeni
della Batracomiomachia di ventidue anni dopo (1833),
ove di nuovo tra animali (i “bruti”) e uomini le differenze
sono riconosciute appena come gradazione di una stessa sostanza.
“Certo esser
dee che dalla intelligenza
De’ bruti a
quella dell’umana prole
E’ qual da
meno a più la differenza,
Non di genere
tal che si rigetta
La materia un
di lor, l’altro l’ammetta.” (VII 12)
Tornando indietro, proprio “scimia” era l’uomo già
nel Dialogo
di un cavallo e un bue (1820), mentre nelle Operette
vere e proprie il dileggio per la specie che s’ostina a
credersi più immagine d’un dio inventato che parte della comune
famiglia di piante ed animali, è sparso un po’ ovunque, e
soprattutto nel divertimento di descrivere una Terra dove
l’umanità s’è da tempo naturalmente estinta.

La certezza (Zibaldone)che
scienza e arte siano accomunate in una stessa intuizione poetica
della natura trova proprio in Leopardi conferme abbaglianti.
E
non solo con Darwin: ogni fisico può raccontare la coincidenza totale tra il Cantico del
gallo silvestre e il secondo principio della
termodinamica che Carnot definì
- casi cosmici - nello stesso anno in cui Leopardi scrisse
l’operetta, il 1824.

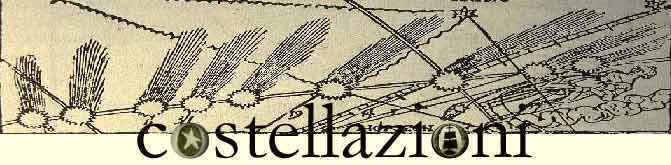
 14.
Charles Darwin
14.
Charles Darwin 




