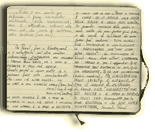"Il
Compagno segreto" - Lunario letterario. Numero3,
marzo 2003
"Il
Compagno segreto" - Lunario letterario. Numero3,
marzo 2003
diari di lettura
Sono, questi tempi, kafkiani?
di Roberto Rossetti
State preparando il numero su Kafka ed è per me difficile scrivere qualcosa, poiché quel grande si associa all'idea della scomparsa di una persona cara, mio padre.
Nel 1990, per non so quale inesplicabile motivo, mi diedi ad una lettura "furente" di Kafka, soprattutto dell'epistolario (le lettere a Milena e la "lettera al padre").
Nella memoria ne serbo un'immagine di una persona meno triste e cupa di quanto l'aggettivo kafkiano comunemente suggerisce, una persona solo consapevole del male che serpeggia nelle società, così come già si andavano delineando nei primi anni del Novecento e di ciò dava atto nei suoi racconti.
Certo, si è trattato di uno scrittore profetico: nel momento in cui scriveva il Processo, ad esempio, non si erano ancora delineati i totalitarismi che colpivano persone, classi e popoli solo in virtù di una colpa originale e, nel contempo, irredimibile:quella di esistere.
Sono, questi tempi, kafkiani?
Malgrado l'abuso dell'aggettivo, credo di no.
Sono tempi vocianti, pletorici, tutto sommato cialtroni.
Mi piace immaginare Kafka in un paradiso di scrittori variopinto e colorato, insieme ad altri grandi tristi, veri o presunti.
Perdonate se ho scritto qualche corbelleria, ma i libri di Kafka li ho sepolti nei recessi meno raggiungibili della mia biblioteca e dal 1990 non ho aperto più un libro del grande Franz.
Buona sera
Roberto Rossetti
Manda il tuo diario di lettura al Compagno segreto
Altri diari: