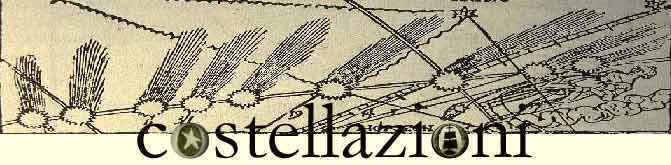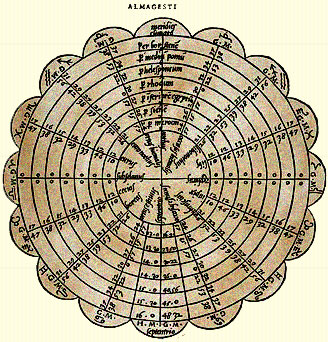«I Francesi giudicano naturale ciò che non
sciocca il loro gusto.»
(W. von Humboldt, Sulla scena tragica
dei francesi, 1800)
Con la Rivoluzione, l’apertura dei teatri, il cosmopolitismo e
l’apertura agli autori stranieri, nei teatri dei Boulevards, tutto
viene trasformato in melodramma: vale anche per Schiller e
Shakespeare. Talma, al Théâtre de la République,
consigliato da David e aiutato dal disegnatore Boucher
azzarda il costume storico in Macbeth…
La spettacolarizzazione in technicolor funziona benissimo. La gente
accorre, ma gli intellettuali restano dall’altra parte. Col Théâtre
Français, Voltaire, Racine, «colonnati stinti, interni scialbi
cieli male illuminati» (M.
Fazio, Il mito di Shakespeare e il teatro romantico, Roma
1992):
per loro Shakespeare è come Hitchcock prima della Nouvelle Vague,
e come si definiva del resto da sé: autore non di tranches de vie
ma de gateaux: troppo spettacolo ed effettacci, troppo
alto il tasso d’incredulità da sospendere. Però la poco
aristocratica Assemblea Nazionale a Parigi conferiva la cittadinanza
onoraria a Schiller (assieme a Washington, Pestalozzi e
Klopstock).

Negli anni di Napoleone (decreto dell’8 giugno del 1806)
Shakespeare viene confinato nei teatri à spectacle:
Hamlet diventa una pantomima tragica con danze ed epilogo
infernale, lo stesso più o meno accadrà per Macbeth e
Otello. Solo un po’ alla volta, infatti, i personaggi
di Shakespeare avranno il permesso di diventare parlanti in Francia.
Nel 1810 esce in Francia, ma subito ritirato dalla censura,
De l’Alemagne di Mme De Staël; sarà leggibile
solo dopo la caduta dell’imperatore, nel 1814: si dice
finalmente – idea appresa da
Schlegel,
precettore dei suoi figli nell’esilio dorato di Copper - che le
culture sono relative, mutevoli, mai “naturali”.