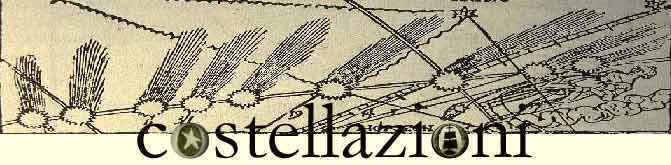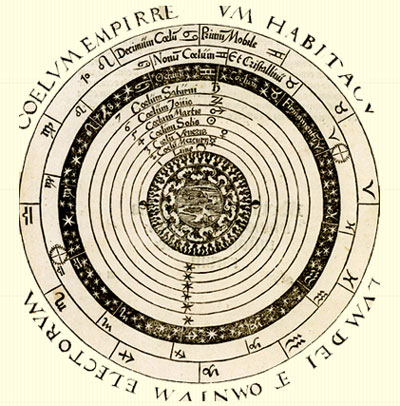«Esistono già due volumi pubblicati di
questo Shakespear che si potrebbero scambiare per delle opere
della fiera, fatte duecento anni fa. Seguiranno altri cinque volumi.
Nutrite un odio adeguatamente forte contro questo sfrontato
imbecille?»
(Voltaire, Lettera a Charles Augustin
Feriol, conte d’Argental, 19 luglio 1776)
Nella stessa lettera Voltaire non può che dolersi di se stesso: «e
per colmo di disgrazia e di orrore sono stato io che un tempo ho
parlato per primo di questo Shakespear; sono io che un tempo ho
mostrato ai Francesi alcune perle che avevo trovato nel suo enorme
letamaio» (Ibid.).
E’ il primo che lo cita in Francia, intorno al 1730, subito
definendo l’atteggiamento fondamentale dei francesi: grande barbara
energia di codesto irregolare di talento. Quarant’anni dopo, sempre
Voltaire, spaventato dal successo di W. S., spostò il peso del
giudizio dalla positività dell’energia sorgiva alla imperdonabilità
della mancanza di regole e misura. Quando l’estetica è tutt’uno con
la politica: «Per Voltaire, per l’Académie, per gli organi ufficiali
della Comédie Française, per la stampa e per il pubblico colto le
regole e il razionalismo erano la Francia stessa» (M.
Fazio, Il mito di Shakespeare e il teatro romantico, Roma
1992)
La prima traduzione di Shakespare (1776-1783) è di
Letoruneur: «una parodia», la definì Victor Hugo, e aveva
ragione: nessuna fedeltà né al testo né allo stile. Non piacque
neppure a Voltaire: «sono adirato con un tale Letourneur, che dicono
sia segretario della biblioteca e che non mi pare un segretario del
buon gusto» (Voltaire, letttera a Charles Augustin Feriol, conte
d’Argental, 19 luglio 1776)

L’anatema di Voltaire dura fino agli adattamenti di Jean-Francois
Ducis (1733-1816), che riscrisse Amleto (1769),
Romeo e Giulietta (1772), Re Lear (1783),
Re Giovanni (1791) e Otello (1792).
Si tratta di riscritture per la scena a partire dalla pessima
traduzione di Letoruneur con drastica semplificazione neoclassica
delle trame e della psicologia dei personaggi. Shakespeare arriva in
scena dunque edulcoratissimo, parla in alessandrini con la rima
baciata e altamente gnomici: roba da ministeri della pubblica
istruzione tutt’oggi.
Però furono l’occasione per scatenare l’arte attoriale di Talma,
il cui talento vagheggino e melanconico trovi più volte descritto
sia nei Ricordi d’egotismo (1832) di
Stendhal che nelle Memorie d’oltretomba di
Chateaubriand.
«Talma recitava gli alessandrini di Ducis come se fossero prosa,
spezzando la cesura simmetrica dl verso per restituirla al senso.
Faceva della pantomima una delle sue principali risorse, mettendo la
sua recitazione muta, il linguaggio e dei gesti, interamente al
servizio della capacità evocativa…» (M.
Fazio, Il mito di Shakespeare e il teatro romantico, Roma
1992).