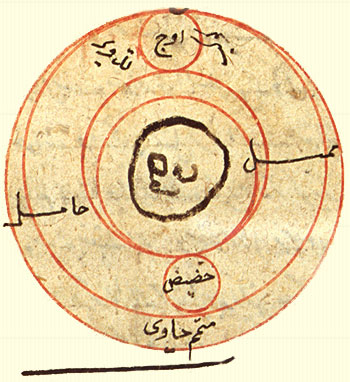(Sul saggio del
1919 contenuto in Ariosto, Shakespeare e Corneille)
«Croce definiva Shakespeare il poeta
cosmico di un mondo di contrasti insoluti, di una realtà misteriosa e
terribile permeata, per la sua stessa imperfezione e mancanza di
autonomia, dal bisogno di una dimensione superiore, di un Dio ignoto
di cui tutti parlano strumentalizzandolo ciascuno ai propri fini.
C’era in quei drammi il rimando a un mondo di realiora che
potrebbero essere terribiliora, un nuomeno di cui tutti i
fenomeni portavano in sé l’attesa trepidante e voluttuosa.
Questo di Croce è uno sforzo
stupendo di caratterizzare il «sentimento» di Shakespeare. non il suo
«pensiero», perché quella vita mostrata in sé sul palcoscenico non si
risolveva in concetti chiari e distinti, ma in amari interrogativi
senza risposta. La filosofia, la morale, il «dover essere», non sono
il campo del teatro. Shakespeare, conclude Croce, può dirsi casomai un
«pre-filosofo».
Ora son passai quasi cent’anni da
quel saggio di Croce, e la saggezza del poi ce lo fa considerare con
ammirazione ma con un certo distacco. Se limite c’è, come in tutte le
cose umane, è nel suo essere un «medaglione» che isola Shakespeare dal
suo contesto e dalla lunga durata culturale (Braudel), proprio
quella a cui invece s’appunta il telescopio rovesciato del qui
presente comparatista, che vede più corte le epoche lunghe, e mette a
fuoco gli elementi meno visibili a occhio nudo della lunga durata. Il
saggio di Croce suona come uno sforzo mirabile di strappare
Shakespeare all’ottimismo panlogista di
Hegel,
per farne un proprio pre-filosofo, un artista antesignano del pensiero
di Croce. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Sotto sotto Croce ha
tirato l’acqua al suo mulino, non diversamente da come han fatto e
sfatto, col libero poetar pensoso dei Greci, con la sapienza
irregolare di quei grandi, tutti i filosofi regolari, da Aristotele a
Emanuele
Severino.»
(N. D’Agostino, Shakespeare e i
greci, Roma 1994)