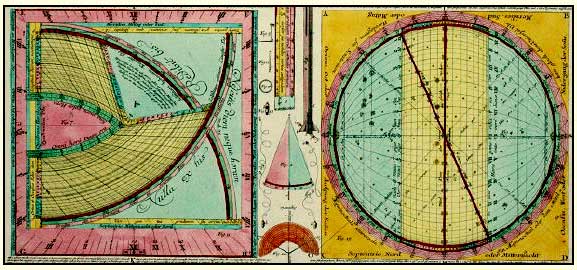Giuseppina Restivo riassume ottimamente il saggio di James
Shapiro, Rival Playwrights, Marlowe, Jonson, Shakespeare,
Columbia Univ. Pr., 1991:
«Tra i due autori Shapiro delinea, dopo l’iniziale imitazione nel
Titus Andronicus, una rivalità costante, una “artistic
struggle” alimentata da un continuo gioco di polemica
contrapposizione di dramma in dramma e da una “parodic response” di
Shakespeare all’eroe marloviano, che dall’Enrico IV si
estende fino al Pirro che fa strage di innocenti a Troia e uccide il
vecchio Priamo inerme in Amleto con evidente ironia
parodica della Dido Queen of Carthage. Anche se
Marlowe muore nel 1593, la ripresa del suo teatro ipereroico
per gli effetti patriottici data la minaccia spagnola dell’Invincibile
Armada, continua da parte di Shakespeare dunque anche dopo la
morte del rivale: e troverebbe secondo Shapiro l’apice proprio in
Amleto dove rispetto al Tamberlaine the Great
le distanze sono evidenti, ma anche una nostalgia per un mondo
anacronistico e barbarico in cui si poteva agire senza rimorsi come
Pirro…».
(G. Restivo, Percorsi della
critica su Amleto, in Tradurre/Interpretare “Amleto”,
Bologna 2002)

«…c’è il fatto che col
blank verse quale Marlowe lo usa (altri lo avevano scoperto
ma nessuno lo aveva reso così mobile e duttile, sottile ed
eloquente, lirico e tragico, intimo e universale), Marlowe
offre al teatro inglese lo strumento con cui esso, a partire da
Shakespeare, si esprimerà. E questo non solo perché lo sostiene
con la sua straordinaria fantasia, la sua ricchezza verbale, la sua
profondità intellettuale, la sua percezione del “sentimento del
tempo”, ma perché ne coglie, e accentua, e impone, tutta la
“teatralità”.
(…)
Grande letterato, grande uomo di
cultura, Marlowe è però, come Shakespeare,
“teatrante”, e sa che il linguaggio del teatro non è quello della
letteratura, che anche i brani più alti, da “antologia” (come per
esempio i monologhi), sono soprattutto brani da “recitare”, parte di
un’azione drammatica, “battuta” che un attore pronuncia davanti a un
pubblico – perché questo, e non altri, è il momento supremo in cui
il teatro si realizza, in cui l’evento teatrale ha veramente luogo.
E se altri elisabettiani sono più abili di Marlowe, sanno costruire
macchine e meccanismi teatrali più robusti, usare espedienti più
sottili, elaborare intrecci più complessi e più spettacolari,
nessuno fa esplodere la teatralità della parola con la violenza con
cui la fa esplodere lui.
(…)
Marlowe
invero inventa la parola teatrale elisabettiana, una parola
cioè (come sarà in Shakespeare, in Webster) che
assolve tutte le funzioni drammatiche: suggerisce una scenografia
(ciò che era fondamentale in un teatro che scenografia non ne
usava), crea tempo e spazio, costruisce l’azione (nessuna battaglia,
nel Tamerlano, viene rappresentata sulla scena ma
tutte vengono evocate verbalmente) e, mentre la costruisce, scava
con le metafore e i simboli nei suoi significati; allo stesso modo,
mentre crea i personaggi e delinea la trama dei loro rapporti con se
stessi, con gli altri, col mondo, con la morte, con Dio, li
approfondisce, ne svela le pieghe più segrete, li proietta in altre
dimensioni – fisiche e spirituali – che non quelle dell’azione
immediata cui appartengono. E per questa parola tesa al massimo
delle sue possibilità, e in effetti protesa al di là di esse,
Marlowe anche inventa un verso che non è solo capace di
assorbirla e contenerla ma ne riproduce, nel suo stesso movimento,
nel suo stesso ritmo, la tensione, la polivalenza e ambiguità, la
tragicità.»
(A. Lombardo, L’eroe
tragico, Roma 2005)