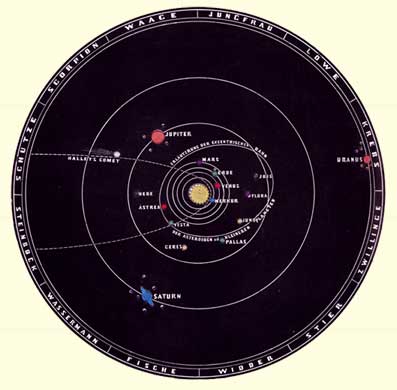POLONIO - Seneca non è troppo grave né Plauto leggero per questa gente…
(Amleto, Atto II, sc. 2)
«Sia in Inghilterra che in Francia è fondamentale, io credo, la
mediazione di Seneca, mai studiato che io sappia come nesso primario
tra i due sistemi tragici al di fuori della trasmissione
aristotelica.»
(N. D’Agostino, Shakespeare e i greci, Roma 1994)

«I drammaturghi elisabettiani
violarono tutte le regole del neoclassico. Infransero le unità,
fecero a meno dei cori, e combinarono intrecci tragici e comici
senza discriminazioni. Il teatro di Shakespeare e dei suoi
contemporanei era el gran teatro del mundo. Esso non
rifiutava di accogliere nessun sentimento, nessun elemento tratto
dal crogiolo dell’esperienza. I drammaturghi elisabettiani e
giacobiti saccheggiarono Seneca. Da lui presero la retorica,
i fantasmi, gli aforismi morali, e il gusto dell’orrido e della
vendetta sanguinosa; ma non le convenzioni austere e artificiose del
teatro neoclassico. Allo spirito della tragedia greca, Shakespeare
oppose una diversa concezione della forma tragica e una diversa
magnificenza di esecuzione.
Malgrado l’abbondanza di
ricerche, la storia di quella forma drammatica rimase oscura.
Marlowe, Kyd e Shakespeare avevano motivi pratici
per abbandonare i modelli neoclassici; un drammaturgo non poteva
guadagnarsi da vivere la vita con i precetti del Castelvetro,
il pubblico preferiva decisamente l’atmosfera romanzesca e turbinosa
della tragicommedia o del chronicle play. Amava i
pagliacci, gli intermezzi comici, le acrobazie e le brutalità
dell’azione fisica. Lo spettatore elisabettiano aveva nervi saldi e
voleva provare emozioni adeguate. Viveva in un mondo violento e
voleva vederlo riprodotto sulla scena. Poeti «eruditi» come Ben
Jonson e Chapman tentarono invano di educare il pubblico
a piaceri più raffinati.»
(G. Steiner, La morte della
tragedia, Milano 1999)

«Ho avuto per le mani una
ristampa diplomatica, in un orrido carattere gothicheggiante
difficilissimo a decifrarsi, delle cosidette tragedie di Seneca,
stampata a Londra nel 1581. Era così famosa
nell’ambiente dei teatri, che il maligno Thomas Nashe
insinuava che i suoi colleghi, compulsandola a lume di candela, ne
ricavavano «molti Amleti». E’ un’opera nota agli anglisti. Una
vernice di stoicismo è spalmata su degli «oratori:, che sembrano
ispirati all’orrore che sarà stata la vita a Roma sotto Nerone.
T.S. Eliot li definì dei «freaks», degli esempi bizzarri di
dramma non teatrale. Nell’ulteriore adattamento dei traduttori
elisabettiani, il pesante latino di Seneca diventa un curioso
linguaggio tra medievale e manieristico. Ma più perdevo gli occhi su
quella mostruosità epocale, più mi rendevo conto che quel libro
somigliava al Socrate descritto dal suo innamorato Alcibiade
nel Simposio: un goffo Sileno di legno, che si apre e
rivela dentro di sé le immagini degli dei. Difatti, si tratta di una
vera scelta, doppiamente adattata, della grande tragedia greca.
Eschilo è riscritto nell’Agamennone, Sofocle
rappresentato dall’Edipo, dall’Ercole Eteo
(dalle stupende Trachinie) e dal Tieste;
il resto, tranne l’Ottavia (che avrà pure
insegnato qualcosa a chi cominciava a scrivere drammi storici) è
calcato su Euripide: Ercole furente,
Medea, Fedra, Fenicie e
Troiane. Una crestomazia che ben riflette la diversa
fortuna di quegli antichi nelle epoche di mezzo: parecchio Euripide,
poco Sofocle e quasi niente Eschilo. Come fanno anche le traduzioni
più brutte e ritoccate, quei rifacimenti elisabettiani riuscivano a
dare una qualche lontana idea degli originali. La tragedia greca era
lì, agonizzante con solo qualche segno di vita, ma abbastanza per
dare a un genio l’idea del suo antico splendore. Shakespeare
compulsò certamente a lume di candela, difatti toni e modi dell’Agamennone
si ritrovano nel Macbeth, una delle più «greche» e
originali delle sue tragedie. Shakespeare aveva pochissimo greco, ma
quel romano di Cordoba, pessimo scrittore di allucinanti e
allucinate tragedie, ebbe il grande merito di accostare Shakespeare
ai Greci.»
(N. D’Agostino, Shakespeare
e i greci, Roma 1994)